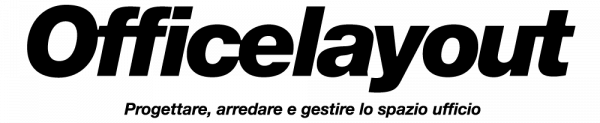La trasformazione degli spazi didattici
Ai nuovi metodi di insegnamento seguono aggiornamenti sui loro spazi: ecco come cambiano Università e luoghi per la didattica, fra nuove tecnologie, aule flessibili e arredi riconfigurabili

Negli ultimi anni gli spazi dell’insegnamento e in particolare le università sono al centro di una profonda trasformazione, guidata da tre fattori principali: l’evoluzione dei metodi di insegnamento, l’avanzamento tecnologico e l’incremento delle risorse economiche rese disponibili dagli stanziamenti previsti dal PNRR. Fattori che spingono verso una ridefinizione del concetto stesso di luogo dell’insegnamento, non più legato apprendimento tradizionale, ma reinterpretato come ecosistema multifunzionale capace di rispondere a esigenze complesse e integrate.
L’adozione di approcci didattici innovativi, come il blended learning – approccio metodologico di tipo ibrido o misto che combina esperienze di apprendimento in presenza e a distanza – e l’apprendimento cooperativo – che persegue l’apprendimento individuale attraverso un processo che vede coinvolto il gruppo distinguendosi sia dall’apprendimento competitivo sia da quello individualistico – richiede ambienti flessibili, in grado di favorire la partecipazione attiva degli studenti. Parallelamente, le tecnologie digitali trasformano aule e laboratori in spazi connessi e interattivi, dove l’esperienza formativa diventa immersiva e personalizzata.
In questo scenario, i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno offerto un’opportunità senza precedenti per ridisegnare le infrastrutture accademiche, con un occhio attento alla sostenibilità, all’accessibilità e al benessere di studenti e docenti.
Fattori che hanno portato molte realtà del settore ufficio a rimodulare la propria offerta con arredi educational che fanno proprio il know-how maturato nello sviluppo di soluzioni per i luoghi di lavoro.
Da qui l’interesse ad approfondire il tema analizzando casi studio e best practice per comprendere come gli spazi universitari si stiano adattando alle esigenze di una società in costante cambiamento.
I recenti progetti per l’Università di Udine firmata Progetto CMR, per il Polo Universitario della Valle d’Aosta di MCA – Mario Cucinella Architects o, facendo un piccolo salto indietro di qualche anno, per la Bocconi di SANAA sono esempi di un nuovo modo di intendere il luogo dell’insegnamento. E quando non si tratta di costruzioni ex novo, il tema diventa la riqualificazione, con un particolare accento sull’inserimento di nuove tecnologie e sulla scelta di arredi in grado di facilitare e assecondare i nuovi metodi didattici, sempre meno incentrati sulle lezioni frontali.
Il percorso di trasformazione degli spazi didattici è dunque legato a numerose variabili, dalla nuova socialità, alla permeabilità verso le città, alle tecnologie in evoluzione, per lezioni che sono sempre più flessibili, coinvolgenti e creative. Un percorso che obbliga a mettere in relazione diverse discipline e professionalità – fra architetti, interior designer, produttori di arredi e specialisti nell’ambito delle tecnologie, per la definizione di spazi contemporanei e con una visione verso il futuro.
Il nuovo approccio all’insegnamento e una rinnovata socialità guidano gli obiettivi del progetto
Cambia la didattica e cambiano i suoi spazi per dare risposte coerenti alla trasformazione in corso. Ma in che direzione va il cambiamento e quali sono le conseguenze sul progetto? Ne parlano i progettisti, autori sul campo di interventi legati al settore delle Università e dei luoghi dell’apprendimento.
Introduce il tema e spiega quali fenomeni hanno maggiormente influenzato il cambiamento Donato Labella, design leader di MCA – Mario Cucinella Architects: “Progettare luoghi dell’apprendimento, come le università, oggi significa pensare a spazi che non sono più solo luoghi fisici dove trasmettere conoscenza in maniera verticale, ma ambienti dinamici creati per favorire la collaborazione, l’interazione e per attivare le idee. Questo risponde a nuovi modelli di insegnamento che guardano all’esperienza e allo scambio di informazioni tra studenti come strumenti per aiutare i giovani a navigare nella complessità del mondo contemporaneo. Un mondo che non può rimanere all’esterno dell’università ma con cui è necessario instaurare un dialogo continuo. Gli edifici universitari, quindi, vanno progettati non come spazi chiusi ma in stretta connessione con il contesto urbano circostante. Devono essere proiettati verso la città, capaci di rispondere alle nuove esigenze della comunità e alle sfide ambientali del nostro tempo. Come nel caso del Polo Universitario della Valle d’Aosta, che, offrendo nuovi spazi di condivisione per la collettività, restituisce alla città una rinnovata socialità. Un edificio che è anche complice dell’ambiente, in quanto costruito a partire dall’analisi delle condizioni climatiche tipiche del luogo, così da essere reattivo e capace di sfruttare al meglio le risorse naturali per alimentarsi”.
Un cambiamento che deve dunque tenere in considerazioni numerosi parametri e abbracciare diverse discipline, da mettere in relazione per creare progetti contemporanei. Urbanistica, architettura, design, psicologia, sociologia sono solo alcune delle aree di approfondimento da analizzare quando si sviluppa un progetto legato a mondo della didattica, come conferma Marco di Russo, senior project manager in ATI Project: “Negli ultimi anni, l’approccio alla progettazione degli spazi universitari e dei luoghi di apprendimento è cambiato profondamente, e sta continuando a evolversi, con un’attenzione crescente non solo alla sostenibilità ambientale, ormai elemento imprescindibile di ogni intervento, ma anche alla socialità, inclusione e apertura alla comunità, e tutti questi aspetti sono ulteriormente potenziati dalla continua innovazione tecnologica. Gli spazi universitari non sono più luoghi pensati solo per lo studio e apprendimento tradizionale; diventano ambienti di condivisione, aggregazione e creatività, dove l’interazione tra studenti, docenti e comunità favorisce lo scambio di idee e la crescita personale e professionale, essenziale per un’esperienza educativa completa. Un fenomeno chiave è la permeabilità tra università e città, che trasforma i campus in estensioni del tessuto urbano, aperti e accessibili non solo alla comunità accademica ma anche ai cittadini. Gli spazi diventano così punti di incontro per la comunità, rafforzando il legame tra istituzione e territorio. Questa apertura, fisica e simbolica, rende le università luoghi inclusivi, accessibili e integrati, promuovendo una cultura dell’apprendimento aperta e collaborativa. In questo contesto, la sostenibilità ambientale si traduce non solo nella realizzazione di strutture resilienti e con un ridotto impatto ambientale, ma anche in una responsabilità condivisa per educare le nuove generazioni a un futuro consapevole, in cui l’attenzione per l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza educativa”.
La trasformazione degli spazi: aule, luoghi della socialità e spazi all’aperto
Studiati e analizzati i parametri citati in precedenza e consapevoli che l’approccio verso il progetto ha subito un’accelerazione verso il futuro, quali sono le conseguenze concrete nel percorso di architettura e interior design? Come cambiano gli spazi? Le nuove aule quali caratteristiche hanno ed è necessario prevedere anche spazi che nel passato non venivano presi in considerazione?
“Gli spazi universitari si stanno trasformando per rispondere a esigenze sempre più varie, legate alle nuove modalità di insegnamento, all’uso sempre più flessibile degli ambienti, alla necessità di essere adattabili anche alle esigenze future imprevedibili”, racconta Marco di Russo che così continua: “molte aule sono progettate con pareti mobili che permettono di unire o separare spazi secondo necessità: unendo alcune aule piccole si può creare un grande ambiente per lezioni più partecipative o eventi, mentre la disposizione degli arredi cambia in base alle attività. Questo significa che le aule possono essere configurate per la didattica intesa in modo più tradizionale, ma anche per lavori di gruppo, seminari, laboratori o attività creative.
Le tipologie di aule variano per dimensioni e funzionalità, e ciascuna ha caratteristiche specifiche: ci sono grandi auditorium e aule magne per lezioni plenarie o conferenze, spazi di studio più intimi che offrono silenzio e concentrazione, e aree pensate come veri e propri ‘hub’ per lavori di gruppo, dove in ognuna di esse si curano e valorizzano in modo particolare la luce, il suono, i colori, per stimolare la creatività. La varietà è ampia e pensata su misura delle necessità di ciascun ateneo, che in fase di progettazione definisce insieme ai progettisti le caratteristiche specifiche degli spazi. Tuttavia, si punta sempre a una flessibilità di fondo, per poter adattare gli ambienti alle mutevoli esigenze future”.
Anche Donato Labella pone l’accento sul principio della flessibilità come elemento centrale nella progettazione dei luoghi dell’apprendimento: “È essenziale superare l’abituale concetto di classe e di lezione frontale, introducendo aule rimodulabili, per esempio attraverso l’uso di pareti scorrevoli, e riorganizzabili sulla base delle esigenze quotidiane della vita accademica. Questi spazi flessibili facilitano sia le attività laboratoriali che quelle di gruppo, trasformando l’ambiente in un vero e proprio attivatore di relazioni e scambio. Alla flessibilità si lega il concetto di intensità d’uso dello spazio, secondo cui uno stesso ambiente può svolgere funzioni differenti, permettendo così di massimizzare l’utilizzo degli ambienti disponibili e riducendo l’impatto del costruito”.
Dalle aule alla città: il ‘nuovo’ progetto tiene in grande considerazione il bisogno di socialità degli studenti e sviluppa soluzioni per mettere in relazione gli spazi della didattica con quelli del nucleo urbano che li ospita, in un incontro fra architettura e urbanistica. “Quando si progettano edifici universitari, è importante non solo pensare agli spazi della didattica, ma preoccuparsi anche di dare ai più giovani luoghi di condivisione e di socializzazione, in cui si sentano accolti e in relazione. Le università, infatti, così come ogni spazio dell’educazione, vanno considerate come un ecosistema dinamico, dove le attività didattiche devono intrecciarsi con la socialità e la vita comunitaria per offrire una crescita umana e personale completa. Nel Polo Universitario della Valle d’Aosta si è deciso, per esempio, di collocare all’ingresso, al piano terra, la caffetteria e l’accesso all’auditorium, due luoghi simbolo di convivialità pensati per essere aperti anche a tutta la città, creando così un punto di incontro tra università e comunità locale”, conferma Donato Labella.
“I luoghi per la socialità si estendono anche all’aperto – puntualizza Marco di Russo –, diventando parte integrante della vita universitaria. Questi spazi sono progettati per favorire la mobilità dolce e ospitare attività educative o di socializzazione all’aperto, dove gli studenti possono rilassarsi, studiare, confrontarsi, fino a organizzare concerti o mostre, collegarsi con il tessuto urbano. È fondamentale creare un ambiente vivibile e sicuro in ogni momento della giornata, in grado di dialogare con la città e farsi sentire parte di essa”.
Più nello specifico, sul costruito e focalizzandosi sul progetto di architettura, dal punto di vista strutturale la flessibilità apre il campo ai sistemi costruttivi a secco e deve tenere sempre in considerazione lo sviluppo impiantistico come racconta Marco di Russo: “Le strutture vengono progettate con sistemi modulari e prefabbricati, che consentono di modificare gli ambienti senza interventi invasivi, e i sistemi impiantistici vengono predisposti per possibili ampliamenti o cambi di destinazione d’uso: ad esempio, un’aula può essere riconfigurata in laboratorio, e gli uffici della docenza possono trasformarsi in open space. Questa attenzione alla progettazione integrata tra architettura, struttura e impianti è la chiave per garantire soluzioni funzionali e allo stesso tempo flessibili, adatte a un futuro ancora in evoluzione”.
Gli arredi per modalità di insegnamento interattive
Dalla progettazione urbanistica e architettonica al percorso di interior design: le nuove Università richiedono, coerentemente, arredi in linea con i cambiamenti nei percorsi didattici. Anche in questo caso la flessibilità è il criterio fondamentale nei progetti per sedie, banchi e soluzioni di nuova generazione. Dalle aziende, la conferma sui cambiamenti in atto e i dettagli sulla ricerca e sviluppo portata avanti in questo campo.
“La proposta per gli spazi didattici si è evoluta nel segno della flessibilità, funzionalità e integrazione tecnologica racconta – racconta Claudia Vedovato, marketing & communication director di Quadrifoglio Group –. La progettazione oggi degli ambienti educativi non si limita a creare semplici aule con banchi e sedie, ma mira a facilitare modalità di apprendimento diversificate, capaci di adattarsi a lezioni frontali, lavori di gruppo e attività di laboratorio. L’uso di mobili modulari, facilmente riconfigurabili, consente agli insegnanti e agli studenti di modificare lo spazio in base alle diverse esigenze, favorendo sia l’interazione sia la concentrazione individuale. Un altro aspetto centrale è l’integrazione della tecnologia: la crescente diffusione di dispositivi digitali richiede arredi che agevolino il cablaggio e la gestione dell’hardware, con postazioni di ricarica e supporti per schermi o tablet. Le merceologie più richieste spaziano fra tavoli con ruote integrate o richiudibili, che agevolano la mobilità o la riconfigurazione rapida degli spazi; sedie ergonomiche, con opzioni di personalizzazione per schienale e braccioli, in modo da ottimizzare comfort e postura; pannelli fonoassorbenti o sistemi di isolamento acustico, ma anche le cabine acustiche, come soluzioni per favorire la concentrazione. Non ultimo, i locker, per offrire a studenti e docenti spazio dove conservare il proprio materiale”.
Flessibilità, tecnologia e comfort sono le tre guide quando si sviluppa un progetto di arredi per la didattica il progressivo passaggio da aule tradizionali a spazi di apprendimento sempre più dinamici ha spinto verso la creazione di arredi che supportino e sostengano modalità di insegnamento collaborative e interattive.
In questo ambito, ci sono alcune soluzioni richieste con maggior frequenza e più pratiche quando l’obiettivo è seguire i cambiamenti nei metodi relativi alla didattica; si tratta soprattutto degli arredi modulari e trasformabili, con una forte integrazione tecnologica.
“La capacità di offrire soluzioni personalizzate, unite a un design raffinato e funzionale, consente di rispondere alle nuove esigenze –specifica Michele Caruso, CEO di LAMM –. Tra i prodotti più richiesti troviamo i banchi studio (sistemi integrati di piani di scrittura e sedute ribaltabili) e le poltrone per auditorium e aule magne. Queste soluzioni, che generalmente richiedono il fissaggio a pavimento per motivi di sicurezza, ottimizzano lo spazio disponibile garantendo un elevato numero di posti. Sono molto apprezzati i sistemi che permettono di trasformare rapidamente una sala conferenze in un’aula polifunzionale, adattandola a diversi contesti di apprendimento. Si osserva inoltre un crescente interesse per l’integrazione di sistemi di elettrificazione e multimediali, così come per gli arredi “flessibili”, capaci di riconfigurare gli spazi in modo rapido a seconda delle attività svolte”.
Nicola Franceschi, managing director di Aresline, presenta la sua esperienza, specificando, in prima istanza, che è necessario dividere gli arredi didattici in due grandi categorie, quelli per le scuole dell’obbligo e quelli per università, scuole superiori e master, pur andando ogni soluzione verso l’integrazione con gli elementi tecnologici. “Nelle Università, le richieste sono ancora per la maggior parte per aule tradizionali con banchi scuola monoblocco con tavolo ribaltabile e forte integrazione tecnologica – racconta Franceschi –. In via secondaria c’è domanda anche per aule polivalenti con sedute facilmente impilabili, in verticale, e accatastabili, in orizzontale, accessoriabili con tavolette scrittoio antipanico, con schienale flessibile e validi sistemi di aggancio. Sempre di più c’è attenzione alla ergonomia e al comfort con sistemi di movimentazione antipanico, silenziosi, più facilmente adattabili agli spazi e alle esigenze del cliente”.
In questo contesto è particolarmente importante lo studio sui materiali come sottolinea Claudia Vedovato: “Per gli spazi didattici, i materiali devono essere resistenti all’usura e facili da mantenere. Quadrifoglio Group ha investito nella ricerca di tessuti performanti e durevoli, e facilmente igienizzabili: grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durabilità, risultano ottimali per ambienti pubblici come quelli didattici. L’applicazione di rivestimenti in essenza melaminica antigraffio, ad esempio, migliora ulteriormente la longevità dei prodotti, rispondendo contemporaneamente alle esigenze di sicurezza e igiene, fondamentali in contesti frequentati da molte persone”.
Michele Caruso aggiunge un parametro di rilievo: la sostenibilità: “Operando principalmente nel settore pubblico, facciamo costante riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), fondamentali per le forniture alla pubblica amministrazione e sempre più richiesti anche in ambito privato. Grazie alle collaborazioni con fornitori di eccellenza, siamo in grado di proporre soluzioni materiche altamente performanti, che coniugano resistenza e sostenibilità, rispondendo così alle esigenze di qualità e rispetto ambientale richieste dal mercato”.
Come ultima nota, in relazione soprattutto all’ottimizzazione della filiera per le aziende produttrici, è interessante notare come gli arredi per gli spazi dedicati alla didattica hanno diversi punti in comune con quelli scelti per gli uffici: ergonomia, flessibilità e integrazione tecnologica, infatti, sono criteri condivisi dai due ambiti e che per mettono ai produttori di proporre soluzioni personalizzabili per diversi contesti, garantendo con costanza gli standard qualitativi e funzionali. “Oggi gli spazi di lavoro sono più fluidi e si utilizzano spesso arredi non convenzionali, le sedute impilabili/accatastabili per aule polivalenti possono essere utilizzate anche per spazi attesa e visitatore, magari con diverse tipologie di finiture, sedili imbottiti e rivestiti, e accessori (4 ruote, braccioli ribaltabili, ecc.)”, conferma Nicola Franceschi.
La tecnologia fra architettura ed esperienza educativa
Nel contesto dei progetti per spazi didattici, la tecnologia è un tema che riguarda sia il percorso di dimensionamento degli impianti e l’installazione di sistemi per ridurre l’impatto ambientale del costruito, sia il livello di comfort e gestione attraverso soluzioni per la connessione, fra piattaforme di prenotazione, intelligenza artificiale, ambienti immersivi, robotica educativa.
I progettisti di MCA – Mario Cucinella Architects e di ATI Project indagano il tema anche dal punto di vista del ruolo nell’ambito del contenimento dei consumi, come spiega Donato Labella citando il recente progetto per il Polo Universitario della Valle d’Aosta: “La tecnologia ha aiutato, in particolare, nel portare avanti la sfida di progettare un edificio pubblico capace di rispondere alle attuali sfide ambientali. È nata una struttura alimentata dalla geotermia, dalle acque di falda e dal fotovoltaico e disegnata con forme che potessero ridurne la domanda energetica. Individuando le potenzialità e le criticità dell’area di intervento, come i percorsi solari, la dinamica delle ombre e l’esposizione ai venti dominanti, è stata studiata una soluzione che permettesse di proteggere l’edificio dalle condizioni metereologiche estreme, sfruttando al contempo le risorse ambientali per sostenerne l’operatività. Un dialogo tra natura e tecnologia che apre la strada alla progettazione di edifici che possano essere in relazione con il contesto in cui si trovano.
Continua Marco di Russo, aprendo il tema anche alle tecnologie sviluppate per arricchire l’esperienza educativa: “La tecnologia gioca un ruolo cruciale nella progettazione degli spazi universitari, contribuendo a garantire comfort, ottimizzare la gestione degli ambienti e ridurre l’impatto ambientale. La sostenibilità è fondamentale non solo nella progettazione e realizzazione degli spazi universitari, ma anche nella loro gestione quotidiana, che grazie all’innovazione tecnologica diventa sempre più consapevole e partecipativa. Sistemi di gestione integrata delle componenti tecnologiche, e strumenti di comunicazione interattiva, permettono non solo di monitorare e ottimizzare l’uso delle risorse, ma anche di sensibilizzare l’intera comunità universitaria a contribuire attivamente a un ambiente più sostenibile. Gli utenti possono, ad esempio, visualizzare dati sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e sui consumi d’acqua, insieme a suggerimenti sui comportamenti che promuovono un uso responsabile di spazi e risorse, diventando così parte attiva della sostenibilità del campus.
Inoltre, le dotazioni tecnologiche interattive e immersive, sempre più integrate nei progetti, arricchiscono notevolmente l’esperienza educativa. Questi strumenti consentono forme di apprendimento attivo, in cui è possibile interagire con i contenuti, esplorare scenari virtuali e partecipare a simulazioni che stimolano la creatività e il pensiero critico. Non si tratta solo di migliorare le infrastrutture fisiche; queste innovazioni ripensano il concetto stesso di spazi universitari, trasformandoli in ambienti inclusivi, connessi e collaborativi.
In questo nuovo contesto, i campus universitari si evolvono in spazi dinamici dove l’apprendimento va oltre a quello tradizionale. Grazie alla tecnologia, si favoriscono interazioni profonde tra studenti, docenti e risorse globali, creando un ambiente educativo che promuove l’inclusione, l’innovazione e una comunità viva e interattiva, pronta ad affrontare le sfide del futuro”.
Arredi high tech
L’interior design si inserisce anche in questo ambito, attraverso proposte innovative in grado di integrare le tecnologie nelle famiglie di arredi per spazi educativi, con l’obiettivo di incontrare le nuove esigenze. “Le soluzioni di arredo con tecnologie integrate assumono un ruolo cruciale negli spazi didattici, rispondendo alle esigenze di un ambiente sempre più dinamico e interconnesso – conferma Claudia Vedovato –. L’integrazione di sistemi come la ricarica wireless, il cablaggio nascosto e i piani di lavoro regolabili elettricamente non solo ottimizza l’uso dello spazio, ma trasforma l’esperienza di apprendimento rendendola più intuitiva e accessibile. L’impiego di tecnologie integrate favorisce inoltre una maggiore flessibilità: ad esempio, postazioni regolabili consentono di personalizzare l’ergonomia in base alle necessità individuali, mentre sistemi di connessione immediata semplificano l’uso dei dispositivi digitali nelle lezioni interattive. Così, gli ambienti didattici si evolvono per diventare ecosistemi dove ogni elemento tecnologico è concepito per sostenere un apprendimento fluido, collaborativo e in linea con le nuove modalità di insegnamento”.
Anche LAMM si sta muovendo in questo ambito, attraverso nell’integrazione di sistemi audio-video e soluzioni digitali direttamente negli arredi, come banchi e poltrone con connessioni per dispositivi elettronici; “stiamo inoltre sviluppando un’innovativa poltrona dotata di batteria ricaricabile al litio, che presenteremo nel 2025 e per la quale abbiamo già ottenuto un brevetto di invenzione industriale”, chiude Michele Caruso.
La scuola digitale
Negli ultimi anni, gli investimenti per la digitalizzazione della scuola in Italia hanno subito un’accelerazione significativa, in gran parte grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Scuola 4.0. La più recente analisi sviluppata dall’Osservatorio EdTech del Politecnico di Milano – nato per esaminare l’offerta del mercato digitale a proposito di servizi e prodotti per la formazione – ha fotografato un settore in grande espansione con un giro d’affari che si attesta a circa 2,8 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 26%, che supera quella del mercato mondiale. In sintesi, dichiarano da EdTech, “l’importanza strategica attribuita alla formazione si riflette in un effettivo aumento degli investimenti in attività formative nell’ultimo anno. Tuttavia, in questo arco di tempo è diminuita la percentuale di allocazione del budget ad attività formative digitali. Questo significa che sta scemando l’interesse nell’investire in forme di digital learning? Non necessariamente. Quello che sembra emergere è infatti uno scenario in cui gli strumenti digitali non prendono il sopravvento sostituendo completamente la formazione in presenza, bensì vengono utilizzati in maniera complementare. Inoltre, in valore assoluto la spesa media in forme. di digital learning è aumentata dai 425.000€ del 2021 agli oltre 480.000€ del 2023”.
Per approfondire l’argomento e capire, sul campo, quali sono le evoluzioni in corso, Officelayout ha chiesto a Marco Bonaventura, channel account manager di Cambium Networks, fornitore di infrastrutture wireless per la banda larga e il Wi-Fi, quali sono le soluzioni più adatte in ambito di didattica: “Negli anni, Internet ha rivoluzionato il metodo di insegnamento e l’essenza stessa della scuola, semplificando processi che vanno dalle operazioni apparentemente più elementari, come l’iscrizione agli esami, fino all’effettiva didattica. I test si svolgono online, mentre le lezioni diventano sempre più ibride, con una parte degli studenti in aula e altri che partecipano da casa o da altri luoghi. Di conseguenza, diventa imperativo avere un’infrastruttura wireless robusta, capace di coprire ogni angolo del campus e di servire efficacemente tutti gli utenti, sia quelli presenti in loco sia quelli collegati da remoto. Per gestire questa complessità, è necessario affidarsi a soluzioni hardware e software che siano robuste e affidabili, ma al contempo semplici da utilizzare e gestibili a distanza, senza la necessità di accedere fisicamente ai dispositivi come access point e ripetitori.
In attesa dell’adozione definitiva dello standard Wi-Fi 7, i dispositivi con supporto a Wi-Fi 6E rappresentano oggi la scelta migliore, offrendo non solo elevate velocità (fino a 9.6 Gbps teorici), ma anche la capacità di connettere simultaneamente numerosi dispositivi. Wi-Fi 6E si distingue per l’utilizzo di tre bande: la banda a 2,4 GHz, che pur avendo la maggior portata è meno veloce e più soggetta a congestione, e le bande a 5 GHz e 6 GHz, che sono meno affollate, offrono velocità superiori ma hanno una portata ridotta a causa dell’attenuazione del segnale dovuta alla presenza di muri e ostacoli.
Un altro fattore rilevante è il supporto al protocollo PoE (Power over Ethernet), che permette l’uso di un unico cavo per trasmissione dati e alimentazione, riducendo il numero di cavi necessari e facilitando l’installazione, in particolare nei campus di grandi dimensioni”.
Per chiudere, la visione di Matteo Ferro, CEO di Ayno, dedicata anche al ruolo della tecnologia in un’ottica di inclusione: “Gli atenei si stanno dotando ormai delle tecnologie più moderne: ogni spazio è progettato per favorire l’interazione e l’accesso ai contenuti digitali. Le aule sono equipaggiate con sistemi di automazione domotica, distribuzione video e lavagne interattive: il tutto fruibile anche a distanza grazie a sistemi di streaming e di cloud collaboration. La didattica deve essere accessibile a tutti: gli studenti in presenza e quelli a distanza devono avere la stessa qualità audio e video e la stessa facilità di accesso ai contenuti. I docenti, invece, devono poter collegare i propri dispositivi rapidamente e in modo interattivo, così da focalizzarsi sulla lezione anziché sulla gestione della tecnologia di sala. La digitalizzazione didattica è un progetto evolutivo e parte fondamentale della strategia nel settore Education. La vera sfida del futuro sarà quella di implementare la modalità “zero distance” a tutte le sessioni formative, affinché non vi sia la percezione di distanza tra i partecipanti, indipendentemente da come o dove sceglieranno di connettersi ovunque si trovino”.